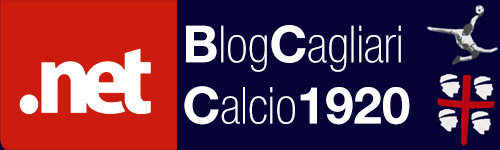Tra le numerose arti e bellezze della Sardegna, una menzione particolare va dedicata all’arte orafa, ed in particolar modo alla filigrana.
Va premesso fin da subito che i gioielli sardi sono i gioielli della “tradizione”, legati al simbolismo del loro significato primario e antico, riconducibile a memorie e tradizioni che ci riportano tanto indietro nel tempo.
Is prendas, i gioielli come vengono chiamati in Sardegna, racchiudono in un unicum la bellezza ed il significato, l’augurio e la storia, la tecnica e l’arte.
La storia dei gioielli sardi ci catapulta indietro nel tempo, tra i miti e le leggende, in un passato in cui i gioielli erano pochi, occasionali, ma soprattutto accompagnati da profondi significati e investiti di una funzione simbolica oltre che ornamentale.
Ed è indubbio che pensare all’arte orafa o comunque alla gioielleria sarda, viene subito in mente il monile più rappresentativo di tutto l’artigianato orafo: la filigrana.
Spesso la filigrana viene definita come un “ricamo in filo d’oro” ed in effetti ricami e gioielli in filigrana sono particolarmente accostabili: da una parte, infatti, i ricami appaiono come gioielli impressi nella stoffa, dall’altra la filigrana sembra un ricamo tanto leggero da librarsi fuori dal tessuto.
Già il nome Filigrana racchiude in sé l’idea del ricamo in quanto, avendo origina dal latino filum e granum, ossia filo e granulo o grano, sembra proprio voler significare un’origine comune, un lavoro prezioso e di alta artigianalità che trae origine dal filum.
Sarebbe però un errore pensare all’origine della filigrana in epoca romana, poiché invece si tratta di una tecnica realizzativa ancora più antica che la fa risalire addirittura da un’antichissima arte orafa egizia, acquisita e migliorata poi dagli etruschi come ci testimoniano le numerose collane, spille, fibbie e bracciali rinvenuti nelle tombe dell’epoca, senza dimenticare i fenici, gli arabi e per finire anche i romani.
Ma qui, ancora per ritornare sulla trama del filo, la storia della filigrana si intreccia con il mito. Questo perché la tradizione popolare ci racconta di piccole dimore incantate, nei luoghi più nascosti della nostra terra, dove piccole fate, le Janas, intrecciavano sapientemente lunghissimi fili d’oro o argento, per creare gioielli unici e splendidi.
Narra la leggenda che la stessa fede sarda abbia origine dalle richieste di giovani innamorati che supplicavano le Janas di creare un anello da donare alle proprie amate, un monile che rappresentasse i due innamorati (i due fili), l’indissolubilità del legame (l’intreccio e le saldature), e la prosperità (il grano).
Ed ecco quindi che un unico anello racchiudeva in sé numerosi significati e valori, promesse e leggende, l’augurio e l’amore.
Ma la fede sarda non è certamente un caso isolato, perché la medesima tecnica è alla base di una ricca tradizione e produzione di bottoni, spille, orecchini, collane ma anche talismani e amuleti.
Oltre alla citata fede sarda, immancabile e sempre bramato, è il bottone sardo la cui nascita è prettamente decorativa degli abiti per le occasioni più importanti e ufficiali, ma che ha assunto un suo valore autonomo indipendentemente dall’abbigliamento o dall’occasione.
È uno dei gioielli più rappresentativi della cultura orafa sarda, usato per chiudere il collo delle camicie e adornare le maniche delle camicie o delle giubbe femminili a formare “sa buttonera”, ma viene anche usato come semplice spilla.
Inutile sottolineare che il materiale e le dimensioni del gioiello erano direttamente proporzionali al ceto sociale della persona che lo donava o indossava.
Il bottone simboleggiava la fertilità e la prosperità, in quanto evocativo del seno materno addirittura della dea fenicia Tanit, protettrice della fecondità.
Altro monile molto amato dalle donne sarde è “sa Mura”, la mora, gioiello dalla classica forma della mora del gelso, ultimo frutto della stagione estiva spesso riservato alle capre e pecore in procinto del parto: questo gioiello infatti era indossato per annunciare alla propria comunità l’arrivo di un figlio.
Molto noto e apprezzato, poi, è “su Coccu”, amuleto di antica foggia, oggi ancora largamente utilizzato come porta fortuna poiché si ritiene avere il potere di difendere la persona dal malocchio, dagli animali velenosi e lenire i mali.
Si ritiene addirittura che la pietra centrale, custodita tra due coppelle in filigrana, sia in grado di neutralizzare, catalizzandolo su di sé, tutto il male che potrebbe danneggiare il suo possessore.
In estrema sintesi quindi, dobbiamo ricordare che ogni monile era insignito di un significato molto preciso e puntuale, non equivocabile, espressione del silenzioso linguaggio del codice agropastorale, dove ad esempio gli orecchini a “pindulu” erano indossati dalle spose o in occasioni importanti; gli orecchini a grappolo, indossati dalle donne degli agricoltori e quelli a pala per le donne delle famiglie dei panificatori; gli orecchini a galletto con “is lantionis”, simbolo del fidanzamento “a fura” cioè ancora senza il consenso della famiglia e quelli a “pittiolus”, per le donne dell’Ogliastra.
E che dire de “Su Lasu”, il tipico ciondolo campidanese formato da “su froccu” (il fiocco), “sa gioia” e su “dominu” (il potere domestico della donna), legato al collo con un nastro di velluto nero dalla sola padrona di casa.
Progetto promosso dalla Regione Sardegna, Assessorato al Turismo